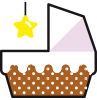T
anto per cominciare, l’Italia non esiste.
È un’espressione geografica, uno stivale che s’allunga pigro nel Mediterraneo, una graziosa penisola purtroppo in gran parte rovinata dagli italiani. L’idea di farne uno Stato, una Na*zione con la maiuscola, come se fossimo la Spagna o l’Inghilterra, è una sciocchezza sesquipedale, che perdoniamo al conte di Ca*vour soltanto perché, maturato nella lingua e nella cultura d’Oltralpe, pensava in buona fede di vivere in Francia.
L’Italia non è mai stata una nazione, e non lo sarà mai. Mi piace pensare che se Cavour avesse vissuto qualche anno in più – abbastanza per conoscere l’Italia – si sarebbe senz’altro dato da fare, con l’arguzia solerte che gli era propria, per smantellare un tale improbabile accrocchio.
Chiunque sia stato una volta nella vita a Cosenza e a Varese – o in qualsiasi altra coppia di città distanti almeno trecento chilometri tra loro – sa benissimo che l’Italia non esiste. Pretendere di esistere è il peccato originale delle nostre classi dirigenti, e la radice primaria di tutti i mali del nostro Paese.
L’unità d’Italia che pomposamente si festeggia o si dileggia, a seconda delle opportunità politiche, è la più grande catastrofe abbattutasi sulla nostra penisola. Meglio dieci Pom*pei,
meglio cento calate degli Unni che l’unità d’Italia. I soli ad avvantaggiarsene vera*mente sono stati i preti, che hanno esteso i confini dello Stato della Chiesa fino a farli coincidere con quelli della penisola. L’Italia unita è un ipertrofico Stato pontificio, dal quale ha ere*ditato le sue due caratteristiche principali: la corruzione e l’ipocrisia.
Prima dell’unità, l’Italia era un buon posto dove vivere. I
Borbone amministravano Napoli e Palermo meglio di quanto gli svizzeri amministrino oggi Zurigo; il Granducato era un faro di cultura e di libertà intellettuale che attirava gli uomini colti di tutta Eu*ropa; il Lombardo-Veneto austriaco era un modello di buongoverno studiato e invidiato nel mondo; i Savoia, prima di oltrepassare il Ticino, erano gente molto seria abituata a go*vernare molto seriamente; e così via, fino all’ultimo minuscolo staterello, felice e prospero e indipendente. L’unico Stato preunitario mal governato e peggio amministrato era lo Stato pontificio: e oggi questo siamo, una vasta, inefficiente suburra di peccatori bigotti.
***
Storicamente, l’idea dello Stato-nazione nasce nell’Ottocento, come lo spiritismo, le fiabe dei fratelli Grimm, il dagherrotipo e l’idealismo tedesco: ha un suo fondamento e, forse, una sua necessità, ma non è un’idea valida per sempre. Nel caso dell’Italia, poi, l’idea di cui parliamo è completamente estranea non soltanto alla sua storia, ma alla sua cultura e alla sua tradizione. Direi persino alla sua civiltà. Nel grande equivoco risorgimentale, al netto delle mire espansionistiche dei Savoia, si legge in nuce una caratteristica fondamentale e duratura dell’italiano medio: co*piare quello che gli altri hanno fatto all’estero, nella convinzione o nella speranza, s’immagina, di dissimulare una natura di cui evidentemente ci si vergogna.
Siccome in Europa la presa dell’impero absburgico andava allentandosi, e si andava dif*fondendo la moda degli Stati nazionali, ad un certo numero di intellettuali nostrani è ve*nuto in mente di salire sull’onda e di inventarsi uno Stato italiano. L’aspetto forse più paradossale della vicenda sta nel fatto che costoro pretendevano di rappresentare la borghesia, motore e soggetto dell’annunciata rivoluzione risorgimentale, mentre è precisamente la borghesia che è sempre clamorosamente mancata nel nostro paese, dove l’unica struttura sociale riconosciuta e funzionante è la famiglia. Non è vero, come a volte si sostiene, che abbiamo inventato il fascismo: lo Stato totalitario di massa arriva a Mussolini (e a Hitler dopo di lui) dall’Unione sovietica; il nostro contributo alla storia dei sistemi politici e delle organizzazioni sociali è la mafia.
Impancandosi a portavoce di una classe che non è mai esistita, la borghesia, gli intellettuali ottocenteschi per il successo dell’impresa decisero persino di inventare una nuova lingua, l’italiano appunto, sciacquando in Arno una koinè immaginaria, e tutta letteraria, e spudoratamente artificiosa, che doveva certo soddisfare qualche accademico e qualche lacché, ma che nessuno, mai, avrebbe parlato.
Secondo le stime di Tullio De Mauro, nel 1860 gli italofoni della penisola erano 600.000, due terzi dei quali concentrati in Toscana, pari al 2,5% della popolazione totale; secondo un altro studioso, Arrigo Castellani, la percentuale complessiva doveva essere un po’ più alta, intorno al 9-10%.
Il risultato centocinquant’anni dopo è miserando: straparliamo come bestie una lingua di cui evidentemente ignoriamo anche gli aspetti più elementari. Importiamo massicciamente parole straniere di cui ignoriamo, oltre alla pronuncia, il significato (su un campione di 158 anglicismi recenti, lo Zingarelli ne registra 121, contro i 42 dello spagnolo Clave e i 34 del francese Petit Robert). In compenso abbiamo smarrito completamente il dialetto, con il quale i nostri nonni contadini riuscivano ad esprimersi perfettamente, e senza fare strafalcioni. L’italiano è sempre stato una lingua letteraria, da Cavalcanti a Calvino, e mai una lingua nazionale. Ora che non esistono più gli scrittori, è una lingua morta.
Questi intellettualini risorgimentali, va sottolineato, importando la moda dello Stato unitario inventarono senza neppure accorgersene la qualità essenziale dell’intellettuale nostrano: il provincialismo. L’erbaccia del vicino, per i nostri intellettuali, è sempre più verde. Si tratta, con ogni evidenza, di un vistoso complesso di inferiorità. Da allora, dalla grande truffa risorgimentale, è stato tutto un rincorrersi di esterofilia militante, e ancor oggi discutiamo accanitamente di modello tedesco e modello francese e cultura anglosassone e spirito americano, e il più brillante è sempre quello che guarda più lontano da casa e la spara più grossa, ci*tando a casaccio studiosi sconosciuti e località ignote, perché così vorrebbe dimostrare, da vero provinciale, di conoscere il mondo.
Fortunatamente, siamo gli unici sul pianeta ad imitare forsennatamente gli altri: a nes*suno, grazie al cielo, è mai venuto in mente di imitare noi.
Del resto, i primi a disprezzare gli italiani furono proprio gli intellettuali risorgimentali, che qualche idea del loro paese se l’erano pur dovuta fare. ”Gl’Italiani – scriveva Massimo d’Azeglio nei Miei ricordi, la cui stesura cominciò nel 1863 – hanno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere gl’Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico la loro rovina; [...] pensano a riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bi*sogna, prima, che si riformino loro”.
È facile cogliere in queste parole un cliché che risale almeno al Settecento, se non prima, e che sarà destinato a trionfare nei centocinquant’anni a seguire come secondo indelebile contrassegno, accanto al provincialismo piccoloborghese, dell’intellettuale italiano: l’antitalianità. L’antitaliano, è bene dirlo subito, è una sottospecie particolarmente rivoltante dell’italiano medio; quasi tutti gli intellettuali e gran parte della sinistra italiana si considerano antitaliani, e questa è senz’altro una ragione sufficiente per comprenderne l’indecoroso, protratto fallimento.
Dall’amara constatazione affidata ai Ricordi – in tutto esatta, ad eccezione del non trascurabile dettaglio che gli italiani non hanno affatto voluto fare l’Italia, ma, al contrario, l’hanno subita supini come ogni altro evento della loro storia, salvo poi, di tanto in tanto, sputare su un cadavere appeso a testa in giù – nasce la battuta che ha reso immortale il marchese d’Azeglio: “Il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani dotati d’alti e forti caratteri. E pure troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto: pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno gl’Italiani”.
È successo, naturalmente, il contrario: gli italiani hanno disfatto l’Italia.
***
Chiunque abbia anche soltanto sfogliato un sussidiario per le scuole elementari, è in grado di comprendere perché l’Italia non esiste, e perché averla fatta è una sciocchezza che trascolora nel crimine. Dal Paleolitico fino al 1861 non c’è mai stato, neppure per una settimana, uno “Stato italiano”. […] L’Italia che gli intellettuali del nostro provinciale Ottocento vogliono unificare, sedotti dalla moda nazionalista esplosa in Europa e invero piuttosto ignoranti di storia nazionale, non è molto diversa – se non per le potenze straniere di riferimento, che mutano come le stagioni – da quella di otto secoli prima. Dopo la disfatta di Napoleone e il Congresso di Vienna che ne seguì (1815), scomparse le Repubbliche di Genova, di Venezia e di Lucca, il controllo della penisola passò dai francesi agli austriaci, grazie alla sovranità diretta sul Lombardo-Veneto e ad una serie di legami e alleanze, dinastici e militari, con pressoché tutti gli Stati italiani.
Il Granducato di Toscana tornò a Ferdinando III di Lorena, che era il fratello di Francesco I d’Austria; sua figlia, Maria Luisa, ex imperatrice dei francesi, ottenne il Ducato di Parma e Piacenza, mentre il Ducato di Modena e Reggio andò a Francesco IV d’Este. I piccoli Ducati di Massa e Lucca furono integrati, rispettivamente, nel Ducato di Modena (1829) e nel Granducato di Toscana (1847). Il Regno delle Due Sicilie, costituito dall’unione delle Corone di Napoli e Sicilia, tornò ai Borbone e strinse un trattato militare con l’Austria. Lo Stato pontificio, reintegrato nei suoi confini pre-napoleonici (il Lazio, l’Umbria, le Marche, la Romagna e parte dell’Emilia), tornò al papa, che si impegnò a mantenere guarnigioni austriache a Comacchio e a Ferrara.
Soltanto il Regno di Sardegna, che comprendeva la Savoia, il Piemonte, la Sardegna e l’ex Re*pubblica di Genova, conservò sotto la guida prudente di casa Savoia una moderata autonomia dall’Austria. E proprio da questo piccolo Regno, da questa propaggine francese della Padania, da que*sta corte di provincia che imparò l’italiano soltanto dopo essersi trasferita a Roma – città che peraltro detestò fin dal primo giorno –, proprio da qui doveva venire nientepopodimeno che l’unità d’Italia!
L’Ottocento, aveva ragione Leopardi, è un secolo stupido e pericoloso. Inna*morato delle magnifiche sorti e progressive figlie di una visione distorta dell’Illuminismo che disprezza l’uomo nel nome dell’Idea con la maiuscola, l’Ottocento ha inventato il marxismo, che è la base teorica di tutti i totalitarismi novecenteschi, e il nazionalismo, cioè la giustificazione morale della guerra moderna, che non distingue fra militari e civili e distrugge indifferentemente case e caserme.
Tutt’altra idea del mondo, e della storia, e dell’uomo avevano i grandi sovrani europei, sovranazionali per nascita – erano tutti, tecnicamente parlando, sanguemisti –, per cul*tura, per educazione, per visione del mondo. S’ispiravano ad Alessandro il Grande e all’impero di Roma, ne coltivavano la visione universalistica e l’idea di fondo del retto governo, che si limita alle grandi scelte e lascia ad ogni popolo, ad ogni città, ad ogni comunità la possibilità di organizzarsi autonomamente secondo il meglio.
L’impero absburgico è l’ultima espressione di quella civiltà universalistica che stiamo ora affannosamente, e maldestramente, cercando di costruire con l’Europa unita. France*sco Giuseppe era molto più avanti di Altiero Spinelli, cui è dovuto capitare di assistere al fascismo, al nazismo, allo stalinismo e alla più grande guerra di tutti i tempi per ren*dersi conto di ciò che ogni principe europeo sapeva perfettamente da trecento anni: i confini sono soltanto un gioco, una convenzione, un ostacolo, un capriccio, una festa di paese, un modo di dire – non sono mai reali, se non nella mente piccina di avventurieri e pensatori egocentrici. “Ai miei popoli…”, diceva Francesco Giuseppe all’inizio di ogni suo discorso: e intendeva dire: “Ciascuno di noi è diverso, ma siamo tutti fratelli.”
L’idea stessa di nazione, a ben vedere, non è che un’altra espressione di quella “mo*rale degli schiavi” che Nietzsche, con ruvida efficacia, indicava come l’origine e la natura del nascente socialismo, che presto diventerà reale e poi nazionale. È infatti l’invidia a muovere i na*zionalisti: vorrebbero anch’essi essere partecipi di quella sovranità universale che, appunto, invidiano all’imperatore, ma non sanno, ignoranti e presuntuosi come sono, che la vera sovra*nità tende all’impersonale, si disperde in un gioco di specchi e di rimandi, e guardandola da vicino diventa sottile sottile, proprio come accade con il potere; in definitiva non esiste: è un simbolo e una convenzione, al cui riparo le comunità e le nazioni, i popoli e le città si autogovernano.
I nazionalisti, che ignorano queste elementari nozioni, dapprima spezzettano la sovranità sovranazionale in tanti frammenti, assegnandosene uno per ciascuno nella speranza di diventare tanti piccoli imperatori; s’accorgono poi che la sovranità non esiste, se non come ombrello dell’autogoverno; come scimmie, cercano il segreto dello specchio guardandoci dietro, e così finiscono per romperlo; accortisi di non aver nulla in mano, costruiscono da sé un nuovo potere, fondato da un lato sull’omologazione dei costumi, delle tradizioni, delle lingue e delle opinioni, e, dall’altro, sull’oppressiva invasività dello Stato in ogni meandro della vita civile, economica, privata, intellettuale. Lo Stato moderno, lo Stato-nazione dei nazionalisti è un abuso di potere sulle comunità e sugli individui inermi.
L’unità d’Europa cui stanno lavorando alacremente frotte di burocrati nazionalisti ha di buono che, recuperando l’idea sovranazionale, finisce giocoforza col mettere in crisi l’idea di na*zione, svelandone l’intima inconsistenza. Quest’idea appartiene a tutti gli effetti alle brutture del Novecento, il quale a sua volta è la sanguinosa messa in pratica delle bizzarre idee del secolo precedente.
La sciocca pa*rentesi unitaria che ancora ci affligge, e che come abbiamo visto non ha alcun fonda*mento storico o culturale, è dunque destinata a concludersi in ogni caso, vuoi per l’eva*porazione della sovranità nazionale verso l’alto delle istituzioni europee o del mercato globale o dell’impero americano, vuoi per l’implosione silenziosa e inarrestabile nelle comunità, nelle culture e nelle civiltà preesistenti.
***
L’Italia, per fortuna, è spacciata. Nell’ultimo secolo l’hanno tenuta insieme a forza prima Mussolini, poi i grandi partiti di massa, e infine Berlusconi. Tolto Silvio Berlusconi, che certo non per caso viene dalla televisione commerciale generalista, e dunque si occupa per mestiere di fasce di pubblico e di picchi di audience, di target pubblicitari e di spot aspirazionali, e molto meno di politica o di virtù civili, oggi non c’è rimasto nessuno – neppure la Nazionale di cal*cio – in grado di rendere credibile la favola dell’Italia unita.
Del resto si tratta di una favola cui nessuno, qui in Italia, ha mai creduto davvero. Così come l’idea stessa dell’unità nazionale è stata il frutto di una moda straniera, similmente gli unici ad averla interpretata con una certa fermezza, e ad aver dunque governato la penisola come se effettivamente si trattasse di uno Stato nazionale, sono stati, a tutti gli effetti, dei non-italiani. L’Italia dei primi anni del Dopoguerra, forse la sola decente dopo il 1870, era retta da stranieri: De Gasperi era stato deputato al Parlamento di Vienna e aveva tra*scorso gli anni migliori della sua vita nelle biblioteche del Vaticano; Togliatti veniva da Mosca e, pur con tutta la geniale flessibilità del personaggio, non se ne era mai veramente allontanato.
Il Partito comunista e la Democrazia cristiana, le due architravi della Prima repubblica, erano in realtà due potenze straniere,
come gli Absburgo o i Borbone, e i loro leader sono stati a tutti gli effetti i vicerè peninsulari dell’Unione sovietica e dello Stato pontificio. Quando hanno cominciato ad italianizzarsi, anche il Pci e la Dc sono rapida*mente diventati inservibili e inguardabili, l’uno sprofondando nell’estremismo parolaio antitaliano, l’altra inabissandosi nella corruzione straitaliana:
negli anni Ottanta anche i comunisti e i democristiani erano finalmente diventati ita*liani.
Anche Mussolini, che un giorno ebbe a dire con estrema saggezza che governare gli italiani non era difficile, ma inutile, utilizza l’idea di nazione, portandola alle sue più estreme, tragiche, ma non meno coerenti conseguenze, soltanto per scopi essenzialmente politici e di potere. È evidente il suo disprezzo inconsolabile per l’Italia, gli italiani,
i preti e il Re (nessuno che prenda sul serio i suoi interlocutori o che li consideri qualcosa di più di scimmie da ammaestrare parlerebbe come parlava il Duce in pubblico). Tutto l’apparato propagandistico-culturale del regime, tuttavia, è subito all’opera per diffondere e promuovere l’italianità in ogni suo aspetto, dalle arti alla toponomastica, dalla Fiat Balilla alla batta*glia del grano. Ma nessuno ci crede davvero, e anche la dittatura finisce rapidamente in burletta (prima che in tragedia).
In generale, nessun modello sociale o statuale immaginato da qualche solerte apostolo dell’umanità e sommariamente assemblato in laboratorio ha alcuna possibilità di funzionare. Normalmente produce infelicità, distruzione e morte; ma fortunatamente non riesce mai a durare a lungo. Gli esempi più vistosi ci vengono dalle società perfette del Novecento:
il comunismo eurasiatico e la sua variante mitteleuropea, il nazionalsocialismo, hanno prodotto più morti di tutto il resto della storia dell’umanità messa assieme, ma dopo settant’anni si sono infine schiantati.
L’unità d’Italia ha avuto conseguenze meno drammatiche, e anzi tendenzialmente ridicole: ma sul piano teorico condivide
con ogni altro modello artificiale di Stato la medesima arroganza intellettuale, la medesima violenza ideologica, e le medesima vocazione al fallimento. Il motivo fondamentale per cui l’Italia non funziona, dunque, è perché esiste. (
www.thefrontpage.it)