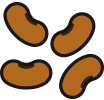Alien.
Advanced Premium Member
[h=3]Cicerchia: deliziosa o velenosa?[/h] La Cicerchia (Lathyrus sativus) è una leguminosa da granella che ha la caratteristica di produrre semi anche in condizioni ambientali difficili, nelle quali nessuna altra pianta commestibile sopravviven e tanto meno, fiorisce.
In epoca storica la cicerchia era diffusa in tutta l’area mediterranea, Italia peninsulare compresa, e nell’Italia del Cinquecento e del Seicento compariva anche sulle tavole dei Grandi, come risulta dalle citazioni in importanti testi gastronomici.
Bene, questa di per se potrebbe non essere una cosa molto interessante, e allora perché la sto raccontando? Perché c’è un inghippo: Il mangiare cicerchie in abbondanza o per periodi prolungati può provocare un’intossicazione con disturbi neurologici agli arti inferiori, dapprima funzionali e reversibili, che se non curati possono arrivare alla paralisi spastica degli arti inferiori con l’impossibilità di deambulare!
Solo negli anni Ottanta dell’Ottocento alcuni medici napoletani collegarono casi di paralisi al consumo di cicerchie e per sottolineare questo rapporto venne coniato il termine latirismo, attualmente spesso sostituito da latiriasi, entrambi derivati da lathyrus, il nome latino della cicerchia, per ribadire il nesso causale fra quel cibo ed i disturbi. I casi osservati non riguardavano residenti in Napoli, ma soprattutto contadini abruzzesi.
Da studi eseguiti una ventina d’anni fa si è chiarita l’etiopatogenesi del latirismo. In pratica le cicerchie (cioè i granelli eduli) contengono una sostanza tossica resistente alla cottura, la beta-N-ossalilammino-L-alanina, indicata con l’acronimo BOAA, che è un amminoacido non facente parte delle proteine e che interferisce con i recettori neuronici per l’acido glutammico, provocando degenerazione delle vie corticospinali, con comparsa dapprima di disturbi funzionali e poi di paralisi spastica irreversibile degli arti inferiori
Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento il latirismo era una malattia riportata nei trattati anche se in maniera imprecisa. Poi negli anni Trenta vi furono dei progressi e adesso anche l’Enciclopedia Italiana (Treccani) menziona la cicerchia alla voce “Tossicologia”, tra gli avvelenamenti di origine alimentare da sostanze quasi costantemente tossiche, erroneamente usate come alimenti: es. pesci velenosi in modo permanente; funghi velenosi; semi di ricino; cicuta scambiata per prezzemolo; semi di mandorle amare o di pesche; semi di cicerchia che determinano il latirismo.
Dopo gli anni Cinquanta, invece, la malattia scomparve dai testi di medicina, non perché fosse stato dimostrato che le cicerchie erano ingiustamente accusate, ma perché oramai, essendo divenute un cibo molto raramente consumato in Italia, non si verificavano più intossicazioni.
Purtroppo negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo ad un ritorno della cicerchia in uno scenario di recupero di cibi tradizionali. Così la Regione Umbria ha inserito la cicerchia fra i prodotti agro-alimentari tradizionali. In Campania la sua popolarità e diffusione è dimostrata dalle frequenti citazioni sulla stampa quotidiana.
Con questo rinnovato interesse per la cicerchia ed il conseguente aumentato consumo è possibile che prima o poi anche in Italia si abbia la ricomparsa di qualche caso di latirismo, la cosa grave è che siamo del tutto impreparati a tale eventualità. Molti medici e molti laureati in agraria ignorano la tossicità della cicerchia, per non parlare della gente comune.
Pubblicato da Camillaa 10:05
In epoca storica la cicerchia era diffusa in tutta l’area mediterranea, Italia peninsulare compresa, e nell’Italia del Cinquecento e del Seicento compariva anche sulle tavole dei Grandi, come risulta dalle citazioni in importanti testi gastronomici.
Bene, questa di per se potrebbe non essere una cosa molto interessante, e allora perché la sto raccontando? Perché c’è un inghippo: Il mangiare cicerchie in abbondanza o per periodi prolungati può provocare un’intossicazione con disturbi neurologici agli arti inferiori, dapprima funzionali e reversibili, che se non curati possono arrivare alla paralisi spastica degli arti inferiori con l’impossibilità di deambulare!
Solo negli anni Ottanta dell’Ottocento alcuni medici napoletani collegarono casi di paralisi al consumo di cicerchie e per sottolineare questo rapporto venne coniato il termine latirismo, attualmente spesso sostituito da latiriasi, entrambi derivati da lathyrus, il nome latino della cicerchia, per ribadire il nesso causale fra quel cibo ed i disturbi. I casi osservati non riguardavano residenti in Napoli, ma soprattutto contadini abruzzesi.
Da studi eseguiti una ventina d’anni fa si è chiarita l’etiopatogenesi del latirismo. In pratica le cicerchie (cioè i granelli eduli) contengono una sostanza tossica resistente alla cottura, la beta-N-ossalilammino-L-alanina, indicata con l’acronimo BOAA, che è un amminoacido non facente parte delle proteine e che interferisce con i recettori neuronici per l’acido glutammico, provocando degenerazione delle vie corticospinali, con comparsa dapprima di disturbi funzionali e poi di paralisi spastica irreversibile degli arti inferiori
Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento il latirismo era una malattia riportata nei trattati anche se in maniera imprecisa. Poi negli anni Trenta vi furono dei progressi e adesso anche l’Enciclopedia Italiana (Treccani) menziona la cicerchia alla voce “Tossicologia”, tra gli avvelenamenti di origine alimentare da sostanze quasi costantemente tossiche, erroneamente usate come alimenti: es. pesci velenosi in modo permanente; funghi velenosi; semi di ricino; cicuta scambiata per prezzemolo; semi di mandorle amare o di pesche; semi di cicerchia che determinano il latirismo.
Dopo gli anni Cinquanta, invece, la malattia scomparve dai testi di medicina, non perché fosse stato dimostrato che le cicerchie erano ingiustamente accusate, ma perché oramai, essendo divenute un cibo molto raramente consumato in Italia, non si verificavano più intossicazioni.
Purtroppo negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo ad un ritorno della cicerchia in uno scenario di recupero di cibi tradizionali. Così la Regione Umbria ha inserito la cicerchia fra i prodotti agro-alimentari tradizionali. In Campania la sua popolarità e diffusione è dimostrata dalle frequenti citazioni sulla stampa quotidiana.
Con questo rinnovato interesse per la cicerchia ed il conseguente aumentato consumo è possibile che prima o poi anche in Italia si abbia la ricomparsa di qualche caso di latirismo, la cosa grave è che siamo del tutto impreparati a tale eventualità. Molti medici e molti laureati in agraria ignorano la tossicità della cicerchia, per non parlare della gente comune.
Pubblicato da Camillaa 10:05