How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Dovresti aggiornarlo oppure usare usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
SIAMO IN PERICOLO
- Creatore Discussione Alien.
- Data di inizio
Alien.
Advanced Premium Member

Maura Tartuffo on Reels | Maura Tartuffo · Original-Audio
1,2 Mio. Aufrufe, 30.712 „Gefällt mir“-Angaben, 458 Kommentare, 6.559 geteilte Inhalte, Facebook Reels von Maura Tartuffo. Maura Tartuffo · Original-Audio
 www.facebook.com
www.facebook.com
Alien.
Advanced Premium Member

Bruno Birindelli on Reels | Bruno Birindelli · Original-Audio
469.600 Aufrufe, 11.107 „Gefällt mir“-Angaben, 673 Kommentare, 6.121 geteilte Inhalte, Facebook Reels von Bruno Birindelli. Bruno Birindelli · Original-Audio
 www.facebook.com
www.facebook.com
Alien.
Advanced Premium Member

Raff Coiro on Reels | Raff Coiro · Original-Audio
98.585 Aufrufe, 1.253 „Gefällt mir“-Angaben, 2 Kommentare, 1.563 geteilte Inhalte, Facebook Reels von Raff Coiro. Raff Coiro · Original-Audio
 www.facebook.com
www.facebook.com
Alien.
Advanced Premium Member
SAI LA VERITA ?

 www.facebook.com
www.facebook.com

Gabriella Finessi on Reels | Gabriella Finessi · Original-Audio
136.853 Aufrufe, 2.201 „Gefällt mir“-Angaben, 275 Kommentare, 3.152 geteilte Inhalte, Facebook Reels von Gabriella Finessi. Gabriella Finessi · Original-Audio
 www.facebook.com
www.facebook.com
Alien.
Advanced Premium Member
SIAMO IN PERICOLO E LO ST*A*TO*!!!
13 GENNAIO 2022 - 16:09
Il Gruppo Solvay fu fondato in Belgio da Ernest Solvay nel 1863. La multinazionale, con sede a Bruxelles, opera a livello internazionale nel settore chimico e delle materie plastiche. Attualmente è presente in 64 paesi ed ha un numero di dipendenti complessivo pari a circa 24.100 unità. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 10.2 miliardi di euro. L’industria Solvay è particolarmente nota per la produzione di carbonato di sodio, il cui processo produttivo viene realizzato mediante l’applicazione del cosiddetto “processo Solvay all’ammoniaca”, ideato dallo stesso fondatore della fabbrica ed oggi internazionalmente utilizzato. La multinazionale Solvay rappresenta attualmente uno dei più importanti gruppi chimici presenti in Italia. La forza lavoro italiana è formata da 1.900 unità, distribuite all’interno di sette siti produttivi localizzati a: Ospiate (Milano), Spinetta Marengo (Alessandria), Mondovì (Cuneo), Livorno, Massa, Rosignano Solvay (Livorno) e Bollate (Milano). In quest’ultima località è presente la direzione nazionale e uno dei più importanti centri di ricerca del Gruppo su scala mondiale. Un’attività che da sempre comporta danni ambientali e di salute rilevanti, sui quali non vi è mai stata la volontà politica di fare chiarezza né tantomeno di agire per proteggere lavoratori e cittadini.
Sversamenti di ammoniaca e morie di pesci lungo le coste di Rosignano
Nel corso degli anni si sono verificati episodi di sversamento ingente di sostanze tossiche nel tratto di costa prospiciente l’impianto Solvay di Rosignano Marittimo. Il 19 giugno del 2007, un black-out elettrico, originò uno sversamento di azoto ammoniacale nelle acque antistanti lo scarico dello stabilimento e l’emissione di fumo dalla torcia dell’impianto di stoccaggio etilene e dalla torcia dell’impianto di produzione polietilene. L’ARPAT quantificò lo sversamento di azoto ammoniacale in circa 11,7 tonnellate (in un periodo di 24 ore) rispetto alle circa 3,67 tonnellate che l’impianto avrebbe scaricato in condizioni di normale funzionamento. La stessa Agenzia in un rapporto conclusivo sottolineò che il disservizio elettrico occorso, pur rappresentando una situazione eccezionale, aveva fatto emergere diversi aspetti critici legati alla sicurezza dell’impianto e relativi, in particolare, alle procedure e dispositivi d’emergenza finalizzati al confinamento di ammoniaca 11. A distanza di dieci anni, in data 29 agosto 2017, in conseguenza di un ulteriore black-out elettrico, si è verificato un nuovo sversamento in mare di ammoniaca che ha determinato una moria di pesci. Le analisi realizzate da ARPAT evidenziarono un aumento della presenza di ammoniaca in mare in una quantità tuttavia non elevatasi al di sopra dei limiti di legge. Le analisi effettuate sui pesci prelevati dall’Istituto di Zooprofilassi di Pisa non vennero effettuate in quanto il cattivo stato di conservazione dei campioni raccolti non ne permise l’analisi.
Scriveva la giornalista Marta Panicucci nel 2015: «Secondo le stime infatti, nel mare turchese delle Spiagge bianche sarebbe concentrato il 42,8% dell’arsenico totale riversato nel mare italiano. Ed il mercurio scaricato dal fosso bianco inquina il tratto di mare di fronte alla fabbrica fino a 14 chilometri dalla costa. La Solvay dai primi anni del ‘900 tramite il fosso che collega direttamente gli impianti al mare, sversa in mare solidi pesanti e metalli come mercurio, arsenico, cadmio, cromo, ammoniaca e solventi organici potenzialmente cancerogeni». Secondo le stime per difetto realizzate dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa nella sabbia bianca la Solvay avrebbe scaricato 337 tonnellate di mercurio ed altri veleni tra i quali figurano arsenico, cadmio, nickel, piombo, zinco, dicloroetano.
Secondo Legambiente nel tratto di mare antistante lo stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo sarebbero state scaricate 500 tonnellate di mercurio, dato riportato anche nel Verbale dell’Osservatorio sull’accordo di programma 2003, vergato presso il Ministero dell’ambiente nel luglio 2009.
Per sapere quali sono le sostanze scaricate attualmente in mare dalla Solvay è necessario consultare la dichiarazione PRTR raccolta nell’E-PRTR, l’European Pollutant Release and Transfer Register, un registro che contiene le informazioni su inquinanti in aria, terra e acqua di tutti gli stabilimenti presenti sul territorio europeo. Consultando la dichiarazione relativa all’anno 2016 si evince che Solvay ha scaricato in mare 2,67 tonnellate di arsenico e derivati (erano 1,449 t. nel 2011), 248 kg di cadmio (erano 91 kg nel 2011 e 183 kg nel 2012), 1,59 t di cromo e 52,6 kg di mercurio (erano 71 kg nel 2011 e 46 kg nel 2012). Rispetto all’anno 2012 nel 2016 è aumentata la quantità scaricata di cadmio e di mercurio mentre è diminuita la quantità scaricata di arsenico e derivati. All’ultima rilevazione disponibile, nel solo 2017, Solvay dichiara di aver scaricato in mare 3,88 tonnellate di arsenico, 3,7 tonnellate di cromo, 59 chili di mercurio e svariati altri inquinanti.
L’abuso di acqua dolce e la rivendicazione di un dissalatore di acqua di mare
Abbiamo già visto che il Rapporto Cheli-Luzzati (Università di Pisa) stimava nel 48% l’uso di acqua dolce del territorio da parte di Solvay. L’altra metà della risorsa idrica doveva e deve soddisfare i consumi prioritari di popolazione ed agricoltura. Un rapporto invertito rispetto ai criteri stabiliti dalla Legge Galli (1994). Nel 2011 la Provincia di Livorno per contrastare “l’uso sconsiderato” dell’acqua da parte dell’industria (non solo Solvay) alza il canone del 3%, che viene fissato in 16.932,11 euro a modulo, cioè 3 milioni di metri cubi, cioè 5 millesimi di euro al metro cubo. Se abbiniamo questo canone stracciato dell’acqua dolce a quello altrettanto stracciato del salgemma, fissato dal Ministero delle finanze (oggi Min. Economia e finanze MEF) in lire 1700 a tonnellata (in euro 0,87 centesimi) nel 1996, si capisce perché Solvay resista a costruire un dissalatore di acqua di mare, da cui ricavi acqua e sale, necessari al suo stabilimento di Rosignano.
Si noti che il polo Solvay, comprese le due centrali elettriche a gas metano, è il secondo emettitore di CO2 in Toscana con 2.200.000 tonn/anno, preceduta dalla geotermia, con 3.000.000 tonn/anno circa, e seguita dalla raffineria ENI di Livorno con 1.100.000 tonn/anno. Il mercurio disperso in atmosfera, inoltre, è stato rilevato in 4 grammi per 1000 kg di cloro prodotto, corrispondenti a 480 kg di mercurio l’anno in atmosfera.
Dal sito di ARS (Agenzia regionale sanità) risultano i seguenti dati riguardanti il comune di Rosignano. La mortalità per tutte le cause è in eccesso sulla Toscana di 13,53 punti nel decennio 2007-2016. La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è in eccesso sulla Toscana di 2,58 punti, 2007-2016. La mortalità per tumore alla mammella è in eccesso a Rosignano sulla Toscana di 9,02 punti, equivalenti al 27,6% di eccesso nel decennio 2006-2015 nella vecchia versione del sito ARS. Sulla nuova versione questo dato di mortalità non appare più, incomprensibilmente. Su 86 femmine decedute nel decennio 2006-2015 per tumore alla mammella, 23,7 sono decedute in eccesso sulla Toscana. I ricoveri per tumori sono in eccesso sulla Toscana di 0,20 punti, 2015-2019. I ricoveri per tumore alla mammella sono in eccesso sulla Toscana di 0,19 punti, 2015-2019. Malformazioni: i nati vivi o soggetti a Interruzione Volontaria Gravidanza che presentavano almeno una malformazione nel decennio 2005-2014 sono in eccesso sulla Toscana di 4,12 punti. I nati vivi di basso peso alla nascita sono in eccesso sulla Toscana di 0,77 punti nel decennio 2009-2018. I malati cronici di diabete mellito sono in eccesso sulla Toscana di 4,1 punti nel 2019. I malati cronici di demenza sono in eccesso sulla Toscana di 0,81 punti nel 2019. Gli Accessi per visite specialistiche sono in eccesso a Rosignano sulla Toscana di 61,19 punti nel 2019.
Mesoteliomi, malattie del sistema nervoso ed Alzheimer
Nello studio a cui partecipò Claudio Marabotti, 2016, si traccia un paragone epidemiologico tra Rosignano (con industria e discarica) e Cecina: “In tutta la Bassa Val di Cecina si sono osservati valori significativamente elevati per i tassi standardizzati di mortalità dovuti a mesotelioma, cardiopatie ischemiche, malattie cerebrovascolari, Alzheimer e altre malattie degenerative del sistema nervoso
Nel comune di Rosignano è stato confermato un eccesso significativo di mortalità per tutte le patologie di questo gruppo. Al contrario, il comune di Cecina mostra solo un tasso significativamente elevato di mortalità dovuta a cardiopatie ischemiche.” “Un legame causale tra la vicinanza agli impianti industriali e il mesotelioma sembra confermato dai presenti dati che mostrano un incremento di mortalità per mesotelioma solo nell’area industrializzata di Rosignano Marittimo.” (…) ” Sia la mortalità per l’Alzheimer che per le malattie cerebrovascolari è significativamente elevata nel comune di Rosignano Marittimo, ciò suggerisce un possibile ruolo patogenetico delle sostanze inquinanti in queste malattie.”
CIOè SI PAGA PER FARCI INQUINARE,AMMALARE E MORIRE ??
l’anno successivo la Solvay ha ricevuto ulteriori 13 milioni di euro di risorse pubbliche(QUELLE RISORSE SIAMO NOI.
E MANGIAMO IL PESCE OTTIMO E SALUTARE.

 www.facebook.com
www.facebook.com
Solvay di Rosignano: un caso esemplare di inquinamento e sperpero di risorse.
13 GENNAIO 2022 - 16:09
Il Gruppo Solvay fu fondato in Belgio da Ernest Solvay nel 1863. La multinazionale, con sede a Bruxelles, opera a livello internazionale nel settore chimico e delle materie plastiche. Attualmente è presente in 64 paesi ed ha un numero di dipendenti complessivo pari a circa 24.100 unità. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 10.2 miliardi di euro. L’industria Solvay è particolarmente nota per la produzione di carbonato di sodio, il cui processo produttivo viene realizzato mediante l’applicazione del cosiddetto “processo Solvay all’ammoniaca”, ideato dallo stesso fondatore della fabbrica ed oggi internazionalmente utilizzato. La multinazionale Solvay rappresenta attualmente uno dei più importanti gruppi chimici presenti in Italia. La forza lavoro italiana è formata da 1.900 unità, distribuite all’interno di sette siti produttivi localizzati a: Ospiate (Milano), Spinetta Marengo (Alessandria), Mondovì (Cuneo), Livorno, Massa, Rosignano Solvay (Livorno) e Bollate (Milano). In quest’ultima località è presente la direzione nazionale e uno dei più importanti centri di ricerca del Gruppo su scala mondiale. Un’attività che da sempre comporta danni ambientali e di salute rilevanti, sui quali non vi è mai stata la volontà politica di fare chiarezza né tantomeno di agire per proteggere lavoratori e cittadini.

L’accordo di programma del 2003
Nel luglio 2003 la Solvay firmò con gli enti territoriali coinvolti un accordo di programma che prevedeva sostanzialmente tre punti: la riduzione degli scarichi a mare del 70% entro l’anno 2007 (da 200.000 a 60.000- tonnellate annue di solidi sospesi); la cessazione del processo produttivo di produzione di cloro e di soda caustica basato sull’elettrolisi a mercurio (altamente inquinante) e sostituzione con quello basato su tecnologia a membrana; la diminuzione dei consumi di acqua dolce di 4 milioni di metri cubi l’anno. In aggiunta ai 30 milioni di euro stanziati in seguito alla firma dell’accordo di programma del luglio 2003, l’anno successivo la Solvay ha ricevuto ulteriori 13 milioni di euro di risorse pubbliche(QUELLE RISORSE SIAMO NOI) provenienti dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia, il Comune e ARPAT e finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali dello stabilimento di Rosignano. Infine, nel 2017, il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Toscana hanno dato il via libera a degli investimenti da parte di Solvay: 52 milioni di euro per un piano di sviluppo per la “tutela ambientale” ma tramite Invitalia hanno dato contributi pubblici per circa 9,5 milioni, che sono ancora oggi da rendicontare.Le indagini del 2008 e il patteggiamento di Solvay
Nel 2008 l’Associazione “Medicina Democratica” presentò un esposto alla Procura di Livorno nei confronti della Solvay in merito al non rispetto dell’Accordo di programma del 2003 e alla presenza di quattro scarichi abusivi sconosciuti all’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e all’utilizzo di una procedura finalizzata a diluire i fanghi di scarico, aggirando così i limiti all’emissione di sostanze nocive previsti dalla normativa vigente. Nel maggio 2013 «dopo quattro anni di indagini, la Procura di Livorno accertò lo scarico illecito di fanghi da parte di Solvay nell’area delle spiagge bianche attraverso “un sistema di scarichi non mappati che permettevano all’azienda di diluire sostanze come mercurio, piombo, selenio e fenoli affinché nel momento in cui questi arrivavano a valle risultavano in regola con i parametri previsti dalle normative di legge».Sversamenti di ammoniaca e morie di pesci lungo le coste di Rosignano
Nel corso degli anni si sono verificati episodi di sversamento ingente di sostanze tossiche nel tratto di costa prospiciente l’impianto Solvay di Rosignano Marittimo. Il 19 giugno del 2007, un black-out elettrico, originò uno sversamento di azoto ammoniacale nelle acque antistanti lo scarico dello stabilimento e l’emissione di fumo dalla torcia dell’impianto di stoccaggio etilene e dalla torcia dell’impianto di produzione polietilene. L’ARPAT quantificò lo sversamento di azoto ammoniacale in circa 11,7 tonnellate (in un periodo di 24 ore) rispetto alle circa 3,67 tonnellate che l’impianto avrebbe scaricato in condizioni di normale funzionamento. La stessa Agenzia in un rapporto conclusivo sottolineò che il disservizio elettrico occorso, pur rappresentando una situazione eccezionale, aveva fatto emergere diversi aspetti critici legati alla sicurezza dell’impianto e relativi, in particolare, alle procedure e dispositivi d’emergenza finalizzati al confinamento di ammoniaca 11. A distanza di dieci anni, in data 29 agosto 2017, in conseguenza di un ulteriore black-out elettrico, si è verificato un nuovo sversamento in mare di ammoniaca che ha determinato una moria di pesci. Le analisi realizzate da ARPAT evidenziarono un aumento della presenza di ammoniaca in mare in una quantità tuttavia non elevatasi al di sopra dei limiti di legge. Le analisi effettuate sui pesci prelevati dall’Istituto di Zooprofilassi di Pisa non vennero effettuate in quanto il cattivo stato di conservazione dei campioni raccolti non ne permise l’analisi.Le problematiche ambientali derivanti dallo stabilimento Solvay di Rosignano: alcuni dati
Nella relazione ARPAT Toscana del 7 giugno 2017 (doc. 2049/1/9), citata nella Relazione Territoriale sulla Regione Toscana, viene elencato, tra i siti oggetto di attività di bonifica, quello di Solvay, avente un’estensione di oltre 220 ettari, che «presenta una contaminazione dei terreni, nonché delle acque sotterranee (falda superficiale e falda profonda) da arsenico, mercurio, composti organoclorurati e PCB [policlorobifenili]. In particolare, per quanto riguarda i composti organoclorurati, le concentrazioni nelle acque sotterranee risultano superiori alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di 3-4 ordini di grandezza. La contaminazione è dovuta alle lavorazioni che sono state effettuate nel corso degli anni nello stabilimento Solvay e ai rinterri di scarti delle lavorazioni avvenuti nel passato. I bersagli della contaminazione delle acque sotterranee sono: 1) i lavoratori esposti ai vapori indoor/outdoor; 2) i pozzi ad uso irriguo delle abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze del sito; 3) le acque superficiali del fiume Fine; 4) le acque superficiali del Mar Ligure (spiagge bianche di Rosignano e Vada)».Scriveva la giornalista Marta Panicucci nel 2015: «Secondo le stime infatti, nel mare turchese delle Spiagge bianche sarebbe concentrato il 42,8% dell’arsenico totale riversato nel mare italiano. Ed il mercurio scaricato dal fosso bianco inquina il tratto di mare di fronte alla fabbrica fino a 14 chilometri dalla costa. La Solvay dai primi anni del ‘900 tramite il fosso che collega direttamente gli impianti al mare, sversa in mare solidi pesanti e metalli come mercurio, arsenico, cadmio, cromo, ammoniaca e solventi organici potenzialmente cancerogeni». Secondo le stime per difetto realizzate dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa nella sabbia bianca la Solvay avrebbe scaricato 337 tonnellate di mercurio ed altri veleni tra i quali figurano arsenico, cadmio, nickel, piombo, zinco, dicloroetano.
Secondo Legambiente nel tratto di mare antistante lo stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo sarebbero state scaricate 500 tonnellate di mercurio, dato riportato anche nel Verbale dell’Osservatorio sull’accordo di programma 2003, vergato presso il Ministero dell’ambiente nel luglio 2009.
Per sapere quali sono le sostanze scaricate attualmente in mare dalla Solvay è necessario consultare la dichiarazione PRTR raccolta nell’E-PRTR, l’European Pollutant Release and Transfer Register, un registro che contiene le informazioni su inquinanti in aria, terra e acqua di tutti gli stabilimenti presenti sul territorio europeo. Consultando la dichiarazione relativa all’anno 2016 si evince che Solvay ha scaricato in mare 2,67 tonnellate di arsenico e derivati (erano 1,449 t. nel 2011), 248 kg di cadmio (erano 91 kg nel 2011 e 183 kg nel 2012), 1,59 t di cromo e 52,6 kg di mercurio (erano 71 kg nel 2011 e 46 kg nel 2012). Rispetto all’anno 2012 nel 2016 è aumentata la quantità scaricata di cadmio e di mercurio mentre è diminuita la quantità scaricata di arsenico e derivati. All’ultima rilevazione disponibile, nel solo 2017, Solvay dichiara di aver scaricato in mare 3,88 tonnellate di arsenico, 3,7 tonnellate di cromo, 59 chili di mercurio e svariati altri inquinanti.
Cloruri
Un “inquinante” del tutto particolare riversato in mare sono i cloruri: non tanto per l’impatto sul mare stesso, ma per quanto dimostra circa l’inefficienza del processo Solvay e per lo spreco di risorse preziose come il sale del volterrano: 901.000 tonnellate nel 2015, 663.000 t. nel 2016, 890.000 t. nel 2017, secondo le dichiarazioni della stessa Solvay al Registro europeo, su un totale di 2.000.000 tonn/anno prelevate da Solvay dalle saline di Volterra: quasi la metà del prelievo di salgemma viene sistematicamente sprecato in mare , con l’aggravante che lo stesso prelievo è costato 6,5 milioni di metri cubi di acqua dolce, sottratta all’uso prioritario della popolazione. L’inefficienza del processo Solvay nel non riuscire a utilizzare tutto il sale immesso nel processo è d’altra parte noto da sempre: lo testimonia il libro celebrativo di Jacques Bolle, Solvay 1863-1963.L’abuso di acqua dolce e la rivendicazione di un dissalatore di acqua di mare
Abbiamo già visto che il Rapporto Cheli-Luzzati (Università di Pisa) stimava nel 48% l’uso di acqua dolce del territorio da parte di Solvay. L’altra metà della risorsa idrica doveva e deve soddisfare i consumi prioritari di popolazione ed agricoltura. Un rapporto invertito rispetto ai criteri stabiliti dalla Legge Galli (1994). Nel 2011 la Provincia di Livorno per contrastare “l’uso sconsiderato” dell’acqua da parte dell’industria (non solo Solvay) alza il canone del 3%, che viene fissato in 16.932,11 euro a modulo, cioè 3 milioni di metri cubi, cioè 5 millesimi di euro al metro cubo. Se abbiniamo questo canone stracciato dell’acqua dolce a quello altrettanto stracciato del salgemma, fissato dal Ministero delle finanze (oggi Min. Economia e finanze MEF) in lire 1700 a tonnellata (in euro 0,87 centesimi) nel 1996, si capisce perché Solvay resista a costruire un dissalatore di acqua di mare, da cui ricavi acqua e sale, necessari al suo stabilimento di Rosignano.Le emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera di Solvay nel 2016 erano dichiarate in 168 tonn. di ossidi di azoto, 327.000 tonn. di anidride carbonica, 6.260 tonn. di ossido di carbonio, 365 di Ammoniaca (NH3), oltre ai biocidi contenuti nei vapori, mai dichiarati dall’azienda.Si noti che il polo Solvay, comprese le due centrali elettriche a gas metano, è il secondo emettitore di CO2 in Toscana con 2.200.000 tonn/anno, preceduta dalla geotermia, con 3.000.000 tonn/anno circa, e seguita dalla raffineria ENI di Livorno con 1.100.000 tonn/anno. Il mercurio disperso in atmosfera, inoltre, è stato rilevato in 4 grammi per 1000 kg di cloro prodotto, corrispondenti a 480 kg di mercurio l’anno in atmosfera.
Grossi finanziamenti pubblici alla Solvay di Rosignano
Ai finanziamenti pubblici già visti sopra, si aggiungono anche i 108 milioni di euro concessi dal MISE (Governo Renzi) e dalla Regione Toscana il 1 dicembre 2016, senza alcuna contropartita, sia occupazionale che ambientale da parte di Solvay.Alcuni aspetti epidemiologici
Rosignano Marittimo è un comune della costa toscana di 30.807 abitanti, che ospita con grande disagio dal 1913 l’unica sodiera italiana, con forti scarichi in aria e in mare (spiagge bianche), due centrali elettriche a gas, un impianto per la produzione di cloro e soda caustica, un altro di polietilene ed uno di acqua ossigenata. Dal 1953 al 1978 ha marciato nell’ambito Solvay l’impianto CVM (cloruro di vinile monomero), chiuso nel 1978 per un’indagine epidemiologica che dimostrava gli effetti cancerogeni e teratogeni dello stesso CVM sulla popolazione di Rosignano Solvay, la frazione più popolata (l’indagine è disponibile presso l’autore e sul sito di MD Livorno). Fuori dagli impianti, Solvay ospita con grande disagio dal 1982 la discarica di Scapigliato, una delle più grandi della Toscana, e dal 2001 il porto turistico Cala dei Medici per 600 posti barca a motore. Vi transita l’Autostrada Genova-Rosignano.Dal sito di ARS (Agenzia regionale sanità) risultano i seguenti dati riguardanti il comune di Rosignano. La mortalità per tutte le cause è in eccesso sulla Toscana di 13,53 punti nel decennio 2007-2016. La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è in eccesso sulla Toscana di 2,58 punti, 2007-2016. La mortalità per tumore alla mammella è in eccesso a Rosignano sulla Toscana di 9,02 punti, equivalenti al 27,6% di eccesso nel decennio 2006-2015 nella vecchia versione del sito ARS. Sulla nuova versione questo dato di mortalità non appare più, incomprensibilmente. Su 86 femmine decedute nel decennio 2006-2015 per tumore alla mammella, 23,7 sono decedute in eccesso sulla Toscana. I ricoveri per tumori sono in eccesso sulla Toscana di 0,20 punti, 2015-2019. I ricoveri per tumore alla mammella sono in eccesso sulla Toscana di 0,19 punti, 2015-2019. Malformazioni: i nati vivi o soggetti a Interruzione Volontaria Gravidanza che presentavano almeno una malformazione nel decennio 2005-2014 sono in eccesso sulla Toscana di 4,12 punti. I nati vivi di basso peso alla nascita sono in eccesso sulla Toscana di 0,77 punti nel decennio 2009-2018. I malati cronici di diabete mellito sono in eccesso sulla Toscana di 4,1 punti nel 2019. I malati cronici di demenza sono in eccesso sulla Toscana di 0,81 punti nel 2019. Gli Accessi per visite specialistiche sono in eccesso a Rosignano sulla Toscana di 61,19 punti nel 2019.
Mesoteliomi, malattie del sistema nervoso ed Alzheimer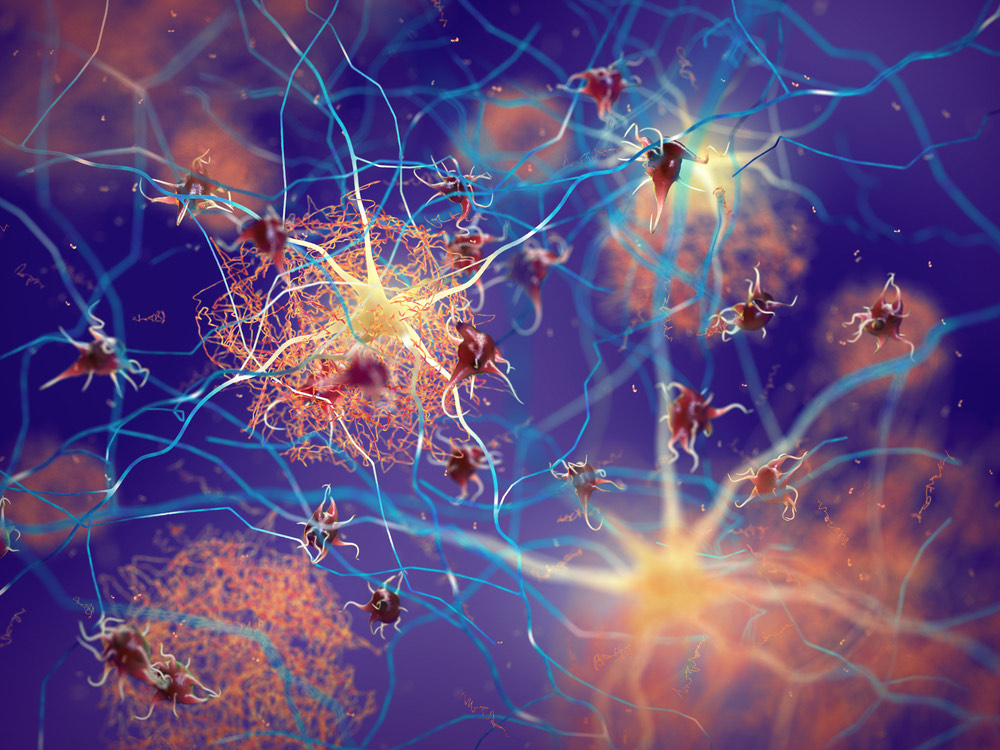
Nello studio a cui partecipò Claudio Marabotti, 2016, si traccia un paragone epidemiologico tra Rosignano (con industria e discarica) e Cecina: “In tutta la Bassa Val di Cecina si sono osservati valori significativamente elevati per i tassi standardizzati di mortalità dovuti a mesotelioma, cardiopatie ischemiche, malattie cerebrovascolari, Alzheimer e altre malattie degenerative del sistema nervosoNel comune di Rosignano è stato confermato un eccesso significativo di mortalità per tutte le patologie di questo gruppo. Al contrario, il comune di Cecina mostra solo un tasso significativamente elevato di mortalità dovuta a cardiopatie ischemiche.” “Un legame causale tra la vicinanza agli impianti industriali e il mesotelioma sembra confermato dai presenti dati che mostrano un incremento di mortalità per mesotelioma solo nell’area industrializzata di Rosignano Marittimo.” (…) ” Sia la mortalità per l’Alzheimer che per le malattie cerebrovascolari è significativamente elevata nel comune di Rosignano Marittimo, ciò suggerisce un possibile ruolo patogenetico delle sostanze inquinanti in queste malattie.”
CIOè SI PAGA PER FARCI INQUINARE,AMMALARE E MORIRE ??
l’anno successivo la Solvay ha ricevuto ulteriori 13 milioni di euro di risorse pubbliche(QUELLE RISORSE SIAMO NOI.
E MANGIAMO IL PESCE OTTIMO E SALUTARE.

3Bee on Reels |
39.305 Aufrufe, 1.176 „Gefällt mir“-Angaben, 29 Kommentare, 6 geteilte Inhalte, Facebook Reels von 3Bee.
 www.facebook.com
www.facebook.com
Ultima modifica:
Alien.
Advanced Premium Member

Maremma avvelenata: acqua contaminata da arsenico e rame dalle ex miniere al mare


Video Player is loading.
Pause
Unmute
0:00
/
0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
Fullscreen
Maremma avvelenata: acqua contaminata da arsenico e rame dalle ex miniere al mare
6 AGOSTO 2015
EMBED
(none)
Acqua contaminata e discariche a cielo aperto che creano paesaggi da film di fantascienza. Non siamo nel casertano e nemmeno nel bresciano. Siamo in uno dei posti più rigogliosi. Siamo in Maremma. L’acqua rossa e poi azzurra, verde e giallina corre veloce lungo le magnifiche colline metallifere. Quei colori però non sono riflessi o giochi di luce. Quei colori sono reali. In Maremma fino alla pianura e al mare che bagna i paesini da Follonica a Castiglione della Pescaia, scorre acqua contaminata. I dati sono ufficiali perché l’Arpat monitora costantemente la zona: arsenico, rame, ferro, manganese e altri metalli colorano di rosso, verde e azzurro quell’acqua la cui portata, se la si osserva da uno dei canali di scolo è impressionante: quasi 300 litri al secondo. «Quest’acqua potrebbe essere usata per varie attività produttive – spiega Roberto Barocci, agguerrito e storico attivista del forum ambientalista di Grosseto, autore di numerosi saggi - eppure le colline e la piana sono quasi del tutto prive di acqua potabile. Queste acque sono definite e pericolose si trovano nel piano di bonifica. Un piano che fissava un tempo di due mesi perché fossero bonificate essendo a rischio la salute umana. Sono però passati 10 anni e la situazione è rimasta invariata: non è stato fatto nulla, nessuna bonifica. Nelle miniere che si trovano in quest’area sono state portate le ceneri di pirite della zona del cosiddetto «Casone» di Scarlino, cioè delle scorie. Di fatto si tratta di discariche autorizzate dalla pubblica amministrazione che avrebbero dovuto rimanere asciutte ma che sono state abbandonate e abbandonando il sistema di drenaggio che manteneva le miniere asciutte, queste ultime si sono allagate con i risultati che si vedono. Di questi canali drenanti nella nostra realtà ce ne sono quattro o cinque E tutta un’area delle colline metallifere oggi è senza acqua potabile». Il fiume Carsia a valle della miniera, si arrampica lungo le colline creando piccole cascate rosse e risulta inquinato da arsenico, manganese e ferro. Basta sfiorare il letto del corso d’acqua per sporcarsi di un sedimento rossastro. «Il Carsia è affluente della Bruna che sfocia a Castiglione della Pescaia – spega Barocci – una splendida cittadina turistica che gode delle bandiere blu assegnate dalle associazioni ambientaliste ma nella stagione delle piogge autunnali spesso accade che i fanghi arrivino fino alla foce e quando questo capita si verificano morie di pesci e animali acquatici».
Le testimonianze
Lodovico Sola è un geologo che fino a 12 anni fa lavorava per una società del gruppo Eni e si occupava di ricerche minerarie. In particolare era il responsabile delle ricerche minerarie fatte in Italia per conto del ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato. Ricerche minerarie che, ci tiene a specificare, si fondavano quasi esclusivamente su prospezioni geochimiche e di verifiche sul terreno. Lui conferma tutto: «A Campiano, quindi nella parte bassa della miniera di Boccheggiano, hanno pensato bene di portarci le ceneri di pirite (inquinate). E così le piogge che si infiltrano attraverso le gallerie e attraverso le spaccature, scendono in profondità, raggiungono le ceneri, disciolgono gli elementi contaminanti che vanno a finire nelle gallerie di scolo». L’ex minatore Carlo Traditi ricorda di aver portato personalmente con la sua squadra, le ceneri di pirite all’interno delle cavità della miniera: «Erano degli spazi enormi e noi abbiamo portato lì quel materiale con dell’attrezzatura normalissima e quindi con al massimo una banale mascherina di carta. Successivamente, ho visto trattare le ceneri che a noi avevano detto di essere innocue, da personale vestito addirittura con degli scafandri. A quel punto ci sono rimasto male. Come è possibile un trattamento così diverso. Perché a noi non è stato detto nulla?». Un altro vecchio minatore Eno Malossi, mi porta lungo il fiume Merse: «Lo vedi è un fiume rosso perché passa nelle zone della galleria della frantumazione dove si inquina dei residui di pirite e quindi l’acqua arriva giù rossa. Ma ora voglio portarti a vedere la discarica più bella del mondo», dice consapevole che le parole discarica e bella difficilmente riescono a stare insieme. Attraversiamo un corso d’acqua, ci arrampichiamo per alcuni metri e il paesaggio che ci si presenta davanti è davvero mozzafiato: sculture rossastre che svettano dal terreno e invadono le rocce e il verde della collina fino al fiume. «Queste sono scorie – dice Eno – È’ ciò che resta del calco pirite cotto e trattato nei primi del Novecento per tirar fuori il rame. Ovviamente, quando piove, queste scorie rilasciano sostanze che finiscono nei corsi d’acqua». «Questa è una realtà antica - aggiunge Barocci - che però concorre con l’inquinamento che abbiamo visto prima ed è proprio perché era già stata segnalata una situazione di inquinamento che è scellerata l’idea di portare all’interno delle cavità della miniera un rifiuto tossico che si sapeva capace di rilasciare arsenico. In questo modo le forme di inquinamento, quella antica e quella moderna si confondono rendendo difficile individuare e delimitare le varie responsabilità». Quella non è l’unica discarica suggestiva della zona. Ce ne sono almeno altre due. Fenice Capanne, che si trova nel comune di Massa Marittima, è un paesaggio lunare. Non ci cresce un filo d’erba da almeno trent’anni. «Spianate e collinette giallastre sono il risultato dell’erosione superficiale dell’abbancamento di rifiuti tossici lasciate in superficie per decenni. - dice Barocci - È una discarica mineraria anch’essa inserita nei piani di bonifica approvati oltre 10 anni fa. Anche questa zona doveva essere bonificata in tempi brevi perché il materiale da qui depositato da 30/40 anni è un materiale pericoloso. Il pericolo non sussiste tanto perché ci sono chilometri quadrati di superficie inquinata ma per l’ erosione che opera costantemente e che fa sì che questo materiale vada a valle, nei fiumi che alimentano la pianura e le falde sotterranee. Falde utilizzate inconsapevolmente dagli agricoltori per irrigare i campi. I dati sulle acque testimoniano la presenza di rame di arsenico ed altri metalli». Scendiamo lungo un corso d’acqua e vediamo che dove c’è ristagno è tutto blu o verde. «Fenice Capanne era una miniera prevalentemente di rame e quindi la dissoluzione dei minerali di rame porta alla produzione di solfati che hanno questa particolare ora colorazione blu verdastro. - dice Sola - I corsi d’acqua pieni di queste sostanze andrebbero bonificati perché cedono rame e gli altri metalli al terreno contaminando così il ciclo biologico».La bonifica
In attesa che la bonifica dell’intera area sia attuata l’Arpat realizza da 7 anni un monitoraggio di tutto l’ambiente acquatico, delle acque uscenti dalla miniera di Campiano, e delle sorgenti. Secondo L’Arpat l’ambiente fluviale mostra una sostanziale stabilità nel corso degli anni con un peggioramento localizzato a valle dello scarico della miniera di Campiano e in corrispondenza delle discariche minerarie chiamate «roste». L’Arpat per l’area di Grosseto è interessata da una grossa attività in quanto la pianura di Scarlino, a valle delle colline metallifere, è il principale sito industriale della provincia. «Le attività produttive tutt’oggi presenti, avviate nella seconda metà del secolo scorso – scrivono i tecnici dell’Arpat - si sono inizialmente basate sulla lavorazione della pirite, minerale proveniente dalle colline metallifere. La lavorazione di questo minerale, con la formazione di drenaggi acidi, ceneri e sterili di pirite, ha fortemente caratterizzato il territorio circostante. Nel corso degli anni, a seguito dell’evoluzione della normativa ambientale, i residui della pirite sono stati identificati come sorgenti primarie di contaminazione, i suoli e le acque a contatto con questi sono considerati inquinati e soggetti a procedimenti di bonifica.Complessivamente l’area è interessata da una quindicina di procedimenti per una superficie complessiva di oltre 2 milioni di metri quadrati Ad oggi sono numerosi i siti bonificati per la matrice suolo (circa il 59% delle suddette superfici); le acque di falda sono invece sottoposte a misure di messa in sicurezza di emergenza e ancora da bonificare (il progetto unitario di bonifica è stato recentemente approvato); prosegue l’opera di individuazione delle ceneri e sterili ancora presenti sul territorio». Continua...Alien.
Advanced Premium Member
Arbus, un fiume di veleni scorre vicino alle dune di Piscinas
di Luciano Onnis
Si aggrava la situazione del rio Irvi: il suo carico di inquinamento mette a rischio l’eden naturalistico
ARBUS. Lo sfregio ecologico del rio Irvi continua a deturpare l’eden naturalistico di Piscinas nel disinteresse generale delle istituzioni. È da anni, praticamente da quando sono state chiuse le miniere (1991) di Montevecchio, il cantiere di Casargiu e la galleria Fais, che dalle gallerie minerarie dismesse e abbandonate sgorgano acque reflue cariche di metalli pesanti nocivi e velenosi (cadmio, arsenico, piombo, nichel, ferro, manganese, cobalto) che poi vanno ad alimentare il rio Irvi, ruscello che attraversa la folta vegetazione di prevalente alta macchia mediterranea e si incunea a valle delle rinomate dune sabbiose di Piscinas – le più alte ed estese d’Europa-, fino a raggiungere il tratto centrale della chilometrica spiaggia e finire quindi in mare.
L’inquinamento di questa vasta porzione di bacino ex minerario a monte dell’oasi naturalistica di Piscinas, affonda nelle diatribe fra Regione, Igea, Provincia del Medio Campidano (ormai ex), con il Comune di Arbus e Asl 6 a fare da spettatori impotenti.
In realtà tutto era iniziato con la vecchia provincia madre di Cagliari che aveva concesso un finanziamento di oltre mezzo milione di euro, diventati poi quasi 800 mila euro, per realizzare un depuratore delle acque reflue svernate dalla galleria Fais del cantiere minerario di Casargiu, neppure quattro chilometri in linea d’aria dal litorale di Piscinas e Costa Verde. I soldi rimasero inspiegabilmente inutilizzati, finché l’importo non venne trasferito, nel 2006, alla neonata Provincia del Medio Campidano, che con i fondi disponibili realizzò un primo modulo dell’impianto, consegnandolo per la sua gestione, nel gennaio 2011, all’Igea, braccio operativo della Regione per il risanamento ambientale delle aree ex minerarie della Sardegna, la quale aveva in cassa un milione di euro, assegnato dalla stessa Regione, per completare e avviare il depuratore di Casargiu.
Di fatto, quell’impianto di depurazione non ha mai visto la luce lasciando così che dalle vecchie miniere continui a fuoriuscire. La recente documentazione fotografica - autore Marco Pietro Mastino durante una escursione di gruppo nelle vecchie miniere di Montevecchio – testimoniano che già con le piogge di fine ottobre la galleria Fais aveva preso a espellere in forte quantità i suoi reflui velenosi. Il fiume rosso sangue (effetto del cadmio e di altri metalli) ha ripreso più che mai vigore. L’effetto visivo è perfino spettacolare: il rosso cupo del rio Irvi che scorre fra il candore delle dune di sabbia, il verde intenso dei ginepri secolari, il cielo e il mare, dipingono un quadro da favola. Peccato che il suggestivo rosso scuro sia il colore di una bomba ecologica a rilascio continuo che nessuno vuole disinnescare.
E DOCE SFOCIANO TUTTI I FIUMI ?
la quale aveva in cassa un milione di euro DOVE è FINITO ? DAI CHE LO SAI ....

Ultima estrazione Lotto
-
Estrazione del lotto
sabato 19 luglio 2025Bari7037366801Cagliari5702643341Firenze1862090506Genova3610743742Milano3907582322Napoli1869283640Palermo7166726423Roma1964397710Torino8363710872Venezia5183265074Nazionale8981633203Estrazione Simbolotto
Nazionale



 1632211903
1632211903

